LA PARTECIPAZIONE AI CIRCUITI INTERLABORATORIO: UNA QUESTIONE DI FORMA E SOSTANZA
Forma e sostanza dovrebbero avere un certo bilanciamento, ma ciò raramente accade.
Accade ancora più raramente quando obblighi bizantini o convenzioni dal retrogusto di misure draconiane costringono i soggetti ad adeguamenti senza senso.
“Più controlli fai, meglio è” è una di quelle castronerie che talvolta ci tocca ascoltare, spostando l’equilibrio verso il paradosso del fiammifero:
controllali tutti, ma alla fine non ne rimane neanche uno da poter utilizzare.
Un po’ come per il test dei terreni pronti in microbiologia: nessun valore aggiunto, nessun senso statistico e nessuna richiesta da parte delle norme pertinenti (v. 6.4.2 della UNI EN ISO 11133:2020).
Partiamo da un concetto semplice: le attività analitiche si basano sulla competenza, ed è proprio la competenza che ci permette di superare i dubbi e valutare gli scostamenti, come anche previsto dalla ISO/IEC 17025 al punto 6.2.3:
“Il laboratorio deve assicurare che il personale abbia la competenza per eseguire le attività di laboratorio per le quali è responsabile e per valutare la significatività degli scostamenti.”
In tale contesto di competenza dovrebbero essere pianificate le attività di assicurazione validità dei risultati (7.7 della 17025), tra cui anche la partecipazione ai PT.
Fermo restando i requisiti stabiliti dal documento Accredia RT-39 (appena pubblicato) il laboratorio dovrebbe pianificare la partecipazione a queste attività tenendo conto di quanto previsto dai seguenti documenti*:
– Guida Eurachem “Selection, use and interpretation of PT scheme by laboratories”,
– Guida EA 4/18 G:2021.
*Oltre queste guide, ulteriori spunti sono forniti dall’allegato C della ISO/IEC 17043:2010, non più presente nella versione della norma del 2023.
Spulciando tra questi documenti si possono individuare alcuni elementi interessanti, ossia che per la partecipazione ai circuiti si dovrebbe considerare anche:
– la rappresentatività del PT
– il numero di partecipanti (quante volte ci siamo trovati io, mammt e tu a partecipare ai circuiti nel settore emissioni?)
– la matrice (quelle analizzate di routine)
– la tecnica (a volte può capitare che in alcuni circuiti sui metalli le tecniche ICP-MS e ICP-OES siano ricomprese assieme; ciò può essere accettabile a patto che vengano eseguite alcune valutazioni statistiche)
– il livello atteso di contaminazione (circuiti per le potabili con livello di contaminazione di E. coli che tipo sei già in galera se distribuisci un’acqua del genere)
– le modalità di valutazione dei risultati: z-score, z’-score, En-score e via così (del significato ne parleremo poi, comunque è tutto spiegato nella guida Eurachem)
– la fattibilità tecnica e il costo (ebbene sì, il costo).
Tutto ciò dovrebbe essere tenuto in conto dai laboratori quando pianificano le attività, perché tanto non è sinonimo di meglio (ne abbiamo parlato al corso dello Studio Arclab s.r.l. sul RT-39 Accredia).
Il nuovo documento Accredia RT 39 fa ritornare attuali alcune vecchie domande.
Decisamente il passaggio dalle sei pagine dell’RT 24 alle ventuno del nuovo documento non semplifica, anzi.
L’ennesimo documento confuso, disallineato e omissivo rispetto alle corrispondenti guide internazionali, in attesa dell’altrettanto ennesimo errata corrige. Ormai una simpatica tradizione.
È proprio vero che bisogna partecipare ad un circuito per ogni metodo?
Il risultato non conforme è sempre “colpa nostra”?
Le carte di controllo applicate agli z-score hanno un senso?
A queste vecchie domande se ne aggiungono altre:
Dobbiamo partecipare anche per i campionamenti? Ma che senso hanno le prove valutative in questo caso?
E le tarature interne, che fanno parte delle “attività non coperte da accreditamento ma che possono influire su quelle coperte”? Ci manderanno una bilancia da tarare, per poi confrontare chissà come i nostri risultati con quelli di altri laboratori, o ci faranno andare a tararne una? Nel primo caso doppia taratura, visto il possibile influsso del trasporto…
Come sviluppare correttamente una specifica analisi dei rischi? Possibilmente evitando le inutili e dannose tabelline colorate del 3×2. Secondo noi si può fare (anzi, si poteva già fare in precedenza, proprio per evitare di buttare tempo e denaro in attività del tutto inutili e foriere di altre complicazioni, precipitando in un circuito vizioso e autoreferenziale, utile solo all’autoerotismo intellettuale dei burocrati e al portafoglio di abili venditori di fuffa.
Per parte nostra abbiamo provato a fornire queste ed altre risposte approfondendo tutti gli aspetti relativi al nuovo documento Accredia ma anche alla gestione dei circuiti interlaboratorio: corretta interpretazione dei requisiti normativi, scelta dell’organizzatore e dei cricuiti, politiche per la definizione delle frequenze, individuazione delle aree di competenza (non più discipline e subdiscipline, anche se sembrano la stessa cosa), utilizzo e interpretazione dei risultati, anche e specialmente di quelli eventualmente non conformi.
I circuiti costano (non solo in termini economici ma soprattutto di cosnumo di risorse del laboratorio: tempo, materiali, stress).
I circuiti servono (se gestiti e utilizzati a dovere).
Partecipare ai circuiti perché “si deve fare” non è certo una buona idea! (anche se “non costano nulla”)
Verranno fornite le indicazioni pratiche per la gestione dei circuiti e dei risultati, i fogli di calcolo per l’elaborazione dei dati per valutare gli andamenti, gli esempi di esempi di procedura e di testo del manuale qualità, in formato word.
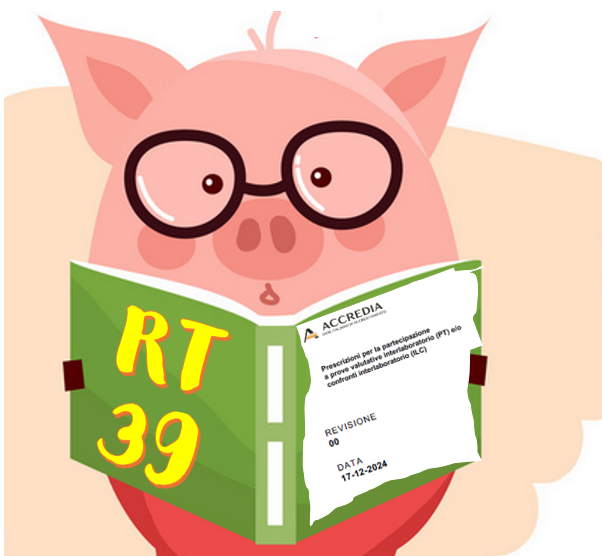
Buongiorno dottore,
ho seguito il corso su RT39 … tutto perfetto e le faccio i miei complimenti.
Forse qualche volta capita che parlando in due vi sovrapponete per qualche frase e si perde qualcosa della conversazione …
Non sono riuscito a capire come un laboratorio di prova si deve comportare riguardo alle tarature interne delle apparecchiature (ne avete parlato solo marginalmente nell’ultima parte del corso).
Noi tariamo internamente bilance e termometri per confronto con una pesiera e un termometro che facciamo periodicamente tarare da un centro LAT.
I laboratori di prova sono obbligati a partecipare a PT per le tarature? (su RT39 è scritto dovrebbero…)
Eventualmente ci sono PT accreditati? (io ne ho trovati un paio ma non sono accreditati per le tarature)
Sono molto costosi (500 euro per ogni circuito) se uno fa quello per le pesate, per le temperature e per i dosatori volumetrici ci vogliono 1500 euro!
La eventuale frequenza di partecipazione?
Nella valutazione basata sul rischio per giustificare una eventuale non partecipazione ai PT tarature si può mettere:
alti costi
PT non accreditati
valori sempre positivi delle partecipazione ai PT per le prove continuando a tarare internamente nel solito modo le apparecchiature che si utilizzano per le varie prove?
Mi può dare qualche suggerimento ?
GRAZIE
Buongiorno dottore, grazie per l’apprezzamento.
Ha centrato il punto: “dovrebbero” (non “devono”). Poi aspettiamo gli sviluppi della questione…
Sconsigliamo vivamente i circuiti sulle tarature, visti i costi, i tempi, e le modalità di esecuzione, come detto nel corso. E poi, la parte analitica “include” gli influssi delle tarature…
Nessuno è interessato alle Tarature interne ?
Qualche laboratorio si è già organizzato ? a trovato qualche soluzione ?
Buongiorno dottore
Immaginiamo sia per quanto riguarda i circuiti interlaboratorio per le tarature interne. Come detto nel corso, il nostro consiglio è di utilizzare l’analisi del rischio per escludere (o diradare di molto, es. ogni 20 anni) la partecipazione. Per ora, come tutti, aspettiamo le mosse dell famoso ente di accreditamento che, praticamente unico in Europa, si è affrettato a regolamentare, diciamo molto vagamente, la questione. Un saluto a Lei (e anche a quelli che ci leggono da via Saliceto: grazie per incrementare il traffico…).